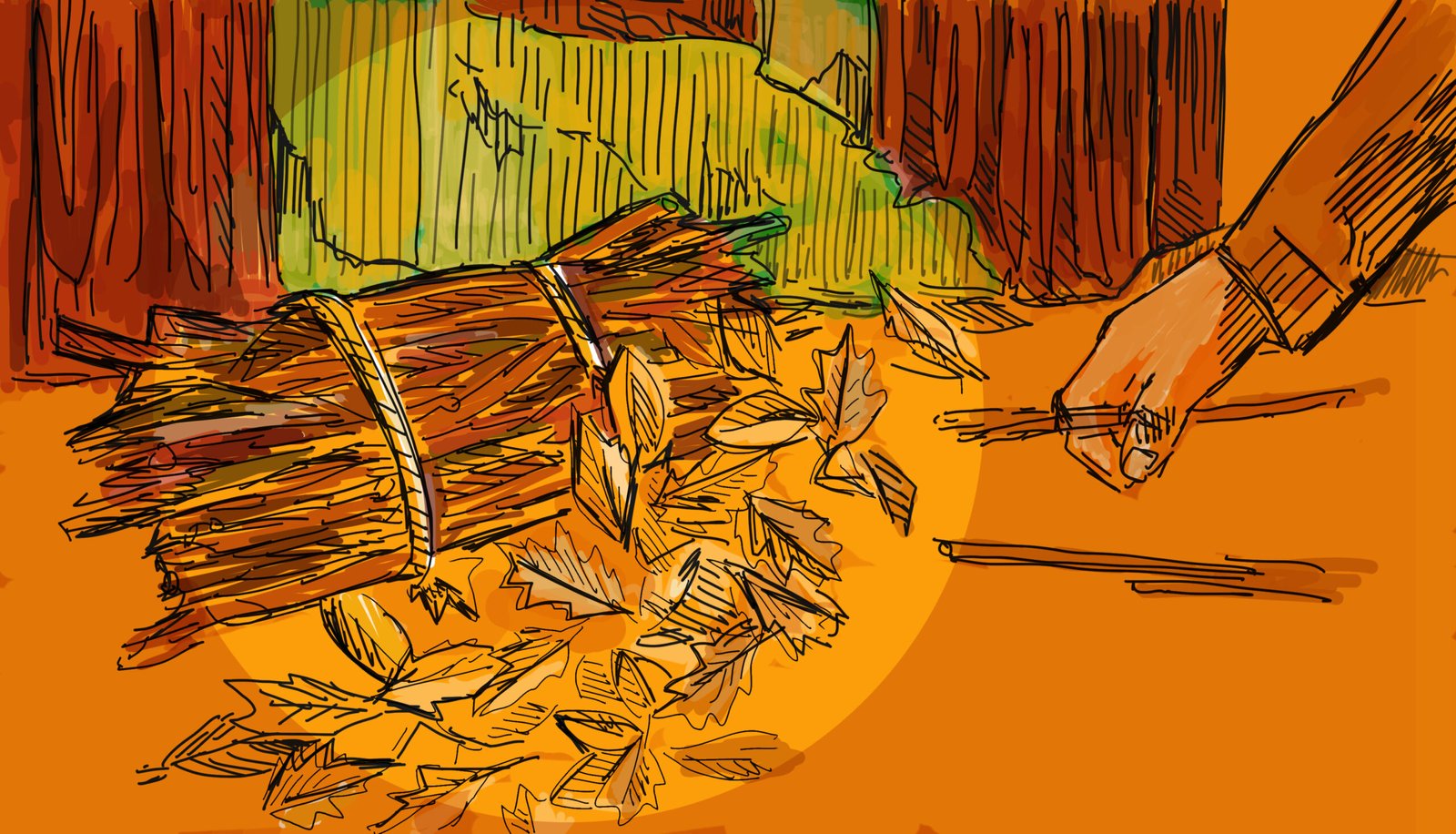Il gatto miagola perché vuole il latte:
il 5% degli italiani non capisce il gatto miagola;
il 33% capisce solo il gatto miagola;
un altro 33% capisce tutta la frase, ma non con altre eventuali subordinate;
il restante 29% capisce frasi anche più complesse.
È uno degli esempi che il linguista Tullio De Mauro (in “La cultura degli italiani. Cultura o incultura?”) ci propone quale indicatore delle nostre competenze linguistiche.
Certo, a molti sembrerà incredibile, ma non bisogna commettere l’errore di pensare che tutti siano come coloro che leggeranno queste riflessioni, frequentatori del web, lettori di giornali, attenti ai temi sociali, politici, o ambientali.
Considerando che nel nostro Paese si assiste quasi a un analfabetismo di ritorno che interessa una bella fetta di italiani, il quadro in cui cimentarsi per una corretta comunicazione sui temi ambientali potrebbe essere piuttosto impegnativo. Comunicare l’ambiente, tenendosi a distanza dalle tendenze documentaristiche televisive di tipo disneyano e da quelle scientifiche dal linguaggio iperspecialistico, è tutt’altro che semplice.
Tra le tante approssimazioni ce n’è una assai nota, quella che narra delle vipere buttate nei prati e nei boschi dagli ambientalisti contro i cacciatori. Una leggenda naturalmente, ma che molti hanno preso sul serio. L’origine? Un numero della Domenica del Corriere del settembre 1976, che allora era venduto in un milione di copie, quindi sfogliato da almeno qualche milione di italiani, che diffuse questa credenza ancora in circolazione nell’immagine di copertina, con un acquerello molto suggestivo.
In Francia, anche prima del ’76, giravano delle immagini assai inquietanti, anche in questo caso dei disegni, che descrivevano il lancio di vipere dagli elicotteri, con tanto di paracadute.
Incredibile, ma circa cinquant’anni fa le percentuali di comprensione degli italiani dovevano essere ancora più allarmanti di quelle riportate sopra.
Comunicare, informare, raccontare, narrare…
La comunicazione ambientale indubbiamente soffre di una sindrome drammatizzante per la quale i media concedono spazio solo in caso di catastrofi, buco dell’ozono, scioglimento dei ghiacci, caos climatico, tsunami e cose del genere. Talvolta il linguaggio è pari al contenuto: frana killer, alluvione assassina, eruzione distruttiva…
Tralasciando gli ormai ovvi elementi di riflessione che rischiano di presentarsi come stucchevoli e ripetitivi sulla convenienza dei costi della prevenzione rispetto a quelli enormi dei disastri, è bene tratteggiare alcune semplici evidenze per proporre l’ambiente in termini positivi e attraenti: occorrono parole semplici per raccontare un mondo sempre più complesso, senza banalizzarlo.
La spettacolarizzazione può essere anche utilizzata, ma in termini positivi e per esaltare temi sempre un po’ negletti, come biodiversità, conservazione, sviluppi possibili.
Un bosco ha un intrinseco valore ecologico, quando lo vogliamo dire? I boschi mantengono il futuro, bisogna inventare slogan, parole d’ordine chiare e immediate; infondere consapevolezza, conoscenza, educazione, perché la cultura è tutela.
Per arrivare a questo bisogna informare, raccontare, narrare le storie; incuriosire, dipanare leggende, accarezzare miti, ritornare all’orgoglio dell’appartenenza di un luogo. L’obiettivo è ampliare il numero di coloro che riescono a leggere la storia di una collina dai colori di un bosco. Il correlato automatico è la creazione di ricchezza ecologica, di consapevolezza ambientale, di partecipazione alle scelte di politica territoriale.
Una comunicazione troppo analitica e razionale può apparire pesante, forse anche fastidiosa, allora forse è meglio rimodulare la prospettiva e accogliere anche il piano più emotivo, irrazionale, dell’animo umano. Privilegiando inventiva e leggerezza, spostando l’accento sui concetti di amore per la natura, piuttosto che solo di rispetto; di azione, piuttosto che di responsabilità; di cosa posso fare io, piuttosto che di che cosa si può fare.
Forse è meglio ricordare che non è il pianeta che deve essere salvato, ma le persone che ci stanno sopra!